
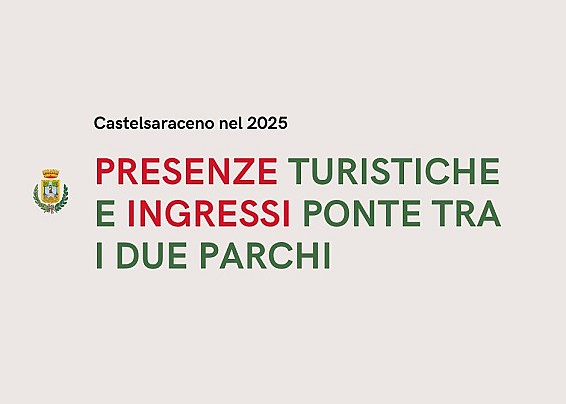
I dati relativi alle presenze turistiche sul territorio e ai biglietti venduti per il ponte tibetano confermano il consolidamento dell’offerta turistica.
Leggi di più
Dal 10 al 12 febbraio 2026 il Comune di Castelsaraceno ha partecipato alla BIT di Milano, confermando per il terzo anno consecutivo una scelta fondata su continuità e visione.
Leggi di più
)-(1)-thumb.jpg)
Per il terzo anno consecutivo, il Comune di Castelsaraceno sarà presente alla BIT di Milano, in programma dal 10 al 12 Febbraio 2026.
Leggi di più
Progetto ANITA, progetto antiviolenza territoriale per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne.
Leggi di più
Nel 2025 l’Amministrazione Comunale ha avviato un’attività strutturata di contrasto all’evasione fiscale, che ha consentito di recuperare € 132.762,92 di entrate tributarie.
Leggi di più.png)
